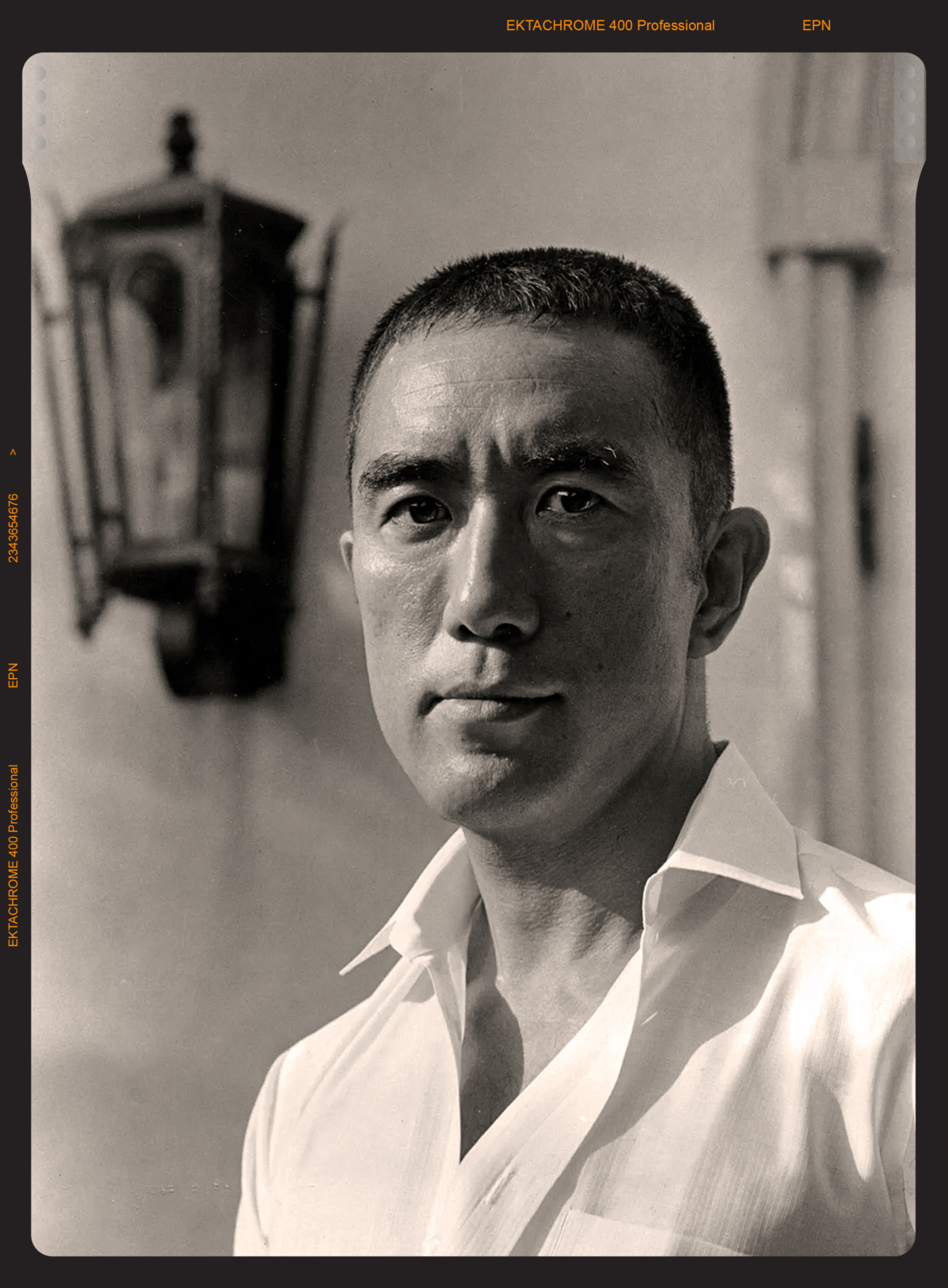Diario di preghiere
Quando cominciai a poco a poco a rialzarmi, dopo essere stata a letto per circa due mesi, la stagione mi sembrò fresca come un kimono appena confezionato. Ora che riacquistavo la salute mi sembrava di stare in piedi sulla riva del mare, le onde si avvicinavano e si ritiravano, e se i miei piedi si bagnavano provavo una piacevole sensazione nel sentirli subito asciugare. La lunga malattia che mi colpì in tenera età rese le mie gambe come quelle di quel piccolo hiruko che fu abbandonato in una barca di giunchi.1 Ricordo che, mentre sonnecchiavo, mi tagliavano le unghie dei piedi e quel rumore mi sembrava il suono di un tamburo che arrivava sino a me dopo aver attraversato laghi e colline. La malattia aveva ridotto le mie gambe a oggetti del tutto estranei al mio corpo, e non fu assolutamente facile riuscire a usarle di nuovo. La mattina dal boschetto del giardino proveniva il cinguettio degli uccelli, la stanza e la veranda erano luminose come l’interno di una bottiglia di vetro e l’acqua del catino, che non avevano ancora portato via, proiettava deboli riflessi sulle assi del soffitto. Ogni mattina, afferrandomi alle mani dell’infermiera, mi sforzavo di camminare dall’estremità della veranda fino alla vecchia e triste finestra a grata da cui si vedeva il cielo chiaro. All’inizio era molto faticoso e quando alla fine giungevo al traguardo, mi afferravo saldamente alla grata, strofinavo sulla finestra la mia piccola testa con i capelli a caschetto e respiravo affannosamente. Quando cominciavo a stancarmi era come se le piante dei piedi poggiassero su una distesa di sabbia bollente, e avevo la sensazione che il piede che avanzava affondasse veloce nel punto in cui lo avevo posato.
Questi esercizi furono ripetuti per alcuni giorni e quando alla fine essi diventarono semplicemente un passatempo quotidiano, l’infermiera Matsumoto decise di portarmi fuori per delle passeggiate. Uscivamo nelle fresche sere prima del tramonto, le prime volte facendo solo due passi intorno alla casa, poi spingendoci un po’ più lontano, alla fine arrivando a camminare fino al tempio alle cui spalle si ergeva una foresta gremita di colombe. Ma vi erano giorni in cui mi stancavo moltissimo e allora sentivo risuonare debolmente in fondo alle mie orecchie un suono simile a quello della carrucola di un pozzo. Quando non ce la facevo proprio più, mi fermavo e mi rivolgevo all’infermiera dicendole:
“Signorina Matsumoto, Yasuko non ce la fa più”.
“Di nuovo la sedia?” mi rispondeva e, senza preoccuparsi del luogo dove si trovava, si accovacciava facendo crepitare lievemente il camice bianchissimo. Allora io mi raggomitolavo sulle sue gambe, su quella sedia bianchissima e splendente, facendo ondeggiare nell’aria le mie scarpette rosse da passeggio.
Il luogo dove si era accovacciata era nei pressi del mercato; era ormai l’ora del tramonto, nel cielo lontano fluttuavano nuvole colorate e le bandiere rosse, gialle e verdi delle baracche sventolavano rumorose. A un tratto dall’angolo della strada vedemmo apparire in controluce qualcosa di bianchissimo che avanzava nella nostra direzione. Quando si fece più vicino capimmo che era un’altra infermiera che conduceva per mano un bambino. lo, che non ero granché interessata alla cosa, guardai in un’altra direzione canticchiando a bassa voce uno stupido motivetto, ma all’improvviso fui afferrata da due mani che con mia gran sorpresa, mi rimisero bruscamente in piedi. Quando mi guardai intorno, vidi che la signorina Matsumoto era intenta a parlare con quell’infermiera senza curarsi affatto di me. In seguito venni a sapere che quella era una sua cara amica che non aveva avuto opportunità di incontrare da tanto tempo. lo, abbandonata così freddamente, ebbi la sensazione che la terra mi scivolasse via da sotto i piedi, ma poiché ero una bambina che non piangeva mai, aiutata in questo dal fatto che tutti lo notavano, trattenni le lacrime con tutte le mie forze. Guardai il bambino che si teneva aggrappato al camice dell’infermiera: aveva un’espressione davvero addolorata, il suo capo era leggermente inclinato verso il basso, mentre gli occhi, un po’ umidi di lacrime, guardavano verso l’alto. Tra la meraviglia di vedere una persona così simile a me e un impercettibile senso di compassione, cominciai quasi senza accorgermene e senza nessuna delicatezza, a guardare fisso il suo viso. Poi all’improvviso avvertii uno strano suono, una specie di gorgoglio d’acqua che sta per versarsi, e mentre pensavo a cosa mai potesse essere, in un attimo il volto del bambino si deformò in un’espressione di pianto. Quel suono che mi aveva così sorpreso non era altro che il preludio alle sue lacrime. Forse il mio sguardo lo aveva messo in imbarazzo, e non sapendo cosa fare era scoppiato a piangere. Le infermiere interruppero subito la loro conversazione e presero entrambe a trastullarlo, poi, visto l’orario, si salutarono e si separarono in tutta fretta. Immersa di nuovo nella solitudine provavo un leggero rimorso, mi sentivo come se fossi stata travolta da una corrente d’acqua…
Due infermiere con lo stesso camice, lo stesso percorso, due bambini della stessa età, e due passeggiate alla stessa ora… queste coincidenze stuzzicavano la mia fantasia. Anche il bambino doveva provare le mie stesse sensazioni. Mi sembrava che fra noi due, nonostante non ci fossimo mai rivolti la parola, queste coincidenze tendessero un filo, evocassero una misteriosa felicità, quella felicità che nasce spesso fra i bambini come un patto silenzioso, come un rito segreto. Ormai se lo osservavo non piangeva più. Ora anche lui riusciva a guardarmi con un’aria un po’ buffa, e così restavamo faccia a faccia, entrambi con un timido sorriso disegnato sui visi tondi e delicati come pesche mature. Lui pure adesso si divertiva con il comodo gioco della “sedia” che fino al nostro incontro non aveva mai visto. Due sedie bianche si allineavano sul ciglio della strada, i due importanti personaggi che vi erano seduti si limitavano a scambiarsi di tanto in tanto qualche sorrisino, mentre le sedie dialogavano fra di loro. II tempo trascorso in questo modo aumentò sempre di più nelle lunghe passeggiate della sera…
Un giorno all’ora di pranzo, la signorina Matsumoto chiese a mia madre il permesso di recarsi alla residenza dove lavorava l’altra infermiera; sapeva che i padroni di casa non c’erano e le avrebbe fatto piacere scambiare quattro chiacchiere con lei dalla cucina. Al suo ritorno io avevo la febbre alta. La signorina Matsumoto, poverina, si scusò sentitamente con mia madre, ma io ero molto arrabbiata. Ero convinta che la febbre mi fosse salita proprio perché lei se n’era andata, così facevo un’infinità di capricci, piangevo e rifiutavo ghiaccio e medicine. La febbre calò presto, ma per un po’ dovemmo interrompere le nostre passeggiate. Trascorsi così alcuni giorni a letto guardando le strisce colorate e i fiori di carta che riempivano il soffitto, e cantando ad alta voce infantili canzoncine. Un pomeriggio di due o tre giorni dopo che mi era venuta la febbre, la cameriera entrò nella stanza e comunicò qualcosa alla signorina Matsumoto, la quale si precipitò in tutta fretta in cucina. Dopo un po’ udii un allegro vociare e capii che era venuta la sua amica infermiera. Pensai di alzarmi e andare di là per spaventarla, ma proprio in quel momento lei rientrò di corsa nella stanza: “Sta entrando il tuo amichetto,” mi disse e ritornò di nuovo in cucina. lo rimasi così sorpresa che fui quasi sul punto di gridare, ma per fortuna riuscii a trattenermi restando immobile con lo sguardo rivolto verso il giardino. Dopo un po’ sentii dietro di me un leggero brusio.
“Signorina, oh che strano, sta dormendo? Il signorino è qui.”
A queste parole diventai d’un tratto docile e, muovendo solo la testa, feci scivolare lo sguardo dal giardino all’architrave della finestra, dall’architrave al soffitto, dal soffitto alla signorina Matsumoto. Quando i miei occhi incontrarono quelli del bambino ci sorridemmo spontaneamente.
“Lui si chiama Yumio, è il figlio della signora Yamagishi, e qual è il nome della signorina?” mi chiese l’infermiera Matsumoto, e io timidamente con un filo di voce risposi solo: “Yasuko”.
Il bambino stringeva al petto un bellissimo libro dorato, dopo alcuni attimi di silenzio lo poggiò sul tatami, si sdraiò bocconi e mi disse: “Ti leggerò una favola”…
Quando ci si è lentamente liberati da una malattia, è difficile rendersi conto che sia stata una liberazione. A me sembrava di essere uscita per caso all’aperto, dopo aver tanto vagato in un lungo labirinto. E dentro il vuoto di quello spazio che ora mi si offriva era difficile trovare il domani, il dopodomani, e un futuro ancora più lontano.
Ora di tanto in tanto mi recavo, mano nella mano con Yumio, in un piccolo tempio shintoista vicino a casa. All’entrata numerosi portali rossi, da cui iniziava a staccarsi la vernice, si ergevano piegati l’uno sull’altro per una decina di metri. Noi non andavamo lì per pregare, ma per verificare una voce a cui tutti i bambini del vicinato credevano fermamente.
Un giorno attraversammo lo stretto lastricato sotto i portali, saltellando come se giocassimo alla campana. Pregammo in gran fretta davanti all’altare e, mentre si sentiva ancora il debole riverbero del grosso sonaglio che avevamo suonato al termine delle nostre preghiere, ci spostammo silenziosamente dietro il tempio. Sul retro dell’edificio c’era un boschetto di bambù, Yumio cadde su una piccola pietra nascosta fra l’erba, e nonostante fosse autunno inoltrato, un nugolo di zanzare che fino a poco prima formavano una colonna immobile si dissolse veloce e senza rumore. In un rialzo del terreno, proprio alle spalle del tempio, c’era un buco abbastanza grande dal quale sembrava fosse stata tolta una grossa pietra. La voce che circolava fra i bambini era che quel buco fosse la tana di una volpe. Davanti a quella cavità qualcuno aveva messo un piccolo piatto bianco con del tofu fritto. 2 Yumio si inginocchiò lì davanti, tutti e due eravamo tesi e con il cuore in gola. Dopo varie esitazioni si decise e infilò la testa nel buco, allora io, senza avvedermene, poggiai una mano sulla sua spalla e gli chiesi ad alta voce: “Si vede? Si vede?”.
“Che male! Non si respira!” mi rispose con la voce attutita dallo spazio angusto e, dimenando pian piano il sedere a destra e sinistra, tirò fuori il capo. Yumio sembrava stesse per piangere, sulla sua lucida testa rapata erano attaccate foglie secche e terriccio, e dall’attaccatura dei capelli sulla fronte penzolavano due o tre fili di ragnatela. Nonostante ciò, io mantenni un’aria distaccata e gli chiesi cinicamente: “C’era la volpe?”.
“No,” rispose e mi sembrò che non riuscisse più a trattenere le lacrime. Senza preoccuparmi minimamente di sporcare il vestito nuovo, mi inginocchiai sul terreno come aveva fatto lui e, sorreggendomi con entrambe le mani al bordo della cavità, vi infilai la testa con molta attenzione. Sentivo la fredda umidità del terreno ricoperto di muschio penetrare fino alle ginocchia, lì dentro c’era un odore simile a quello che si avverte quando si apre una vecchia cassapanca. Avevo la sensazione che le tenebre mi facessero bruciare gli occhi. Per vedere meglio infilai la testa ancor più dentro, al punto che le spalle quasi toccavano il bordo della cavità e guardai intorno. A un tratto in quel buio pesto mi sembrò veder passare di sfuggita una cosa bianca. Sbattendo più volte contro le pareti del buco tirai fuori la testa in gran fretta e, piantatami davanti a Yumio che se ne stava lì immobile e sbalordito, gli dissi sgranando gli occhi: “La volpe c’è!”. Come per una muta intesa, tutti e due cominciammo a tremare di paura, il cuore ci batteva all’impazzata. Senza più una parola e senza neanche guardarci in viso, ci precipitammo fuori del tempio.
Tratto da Yukio Mishima, La foresta in fiore, pubblicato da Feltrinelli